Mentre la funzione del Notaio, come la si intende ai giorni nostri, affonda le sue radici nell’Italia Longobarda e nella Francia Merovingia, il termine “Notarius”, risale al periodo della Repubblica romana. Con tale termine si soleva indicare lo schiavo che aveva il compito di scrivere velocemente note, spesso mediante abbreviature.
Durante il periodo della decadenza dell’Impero romano i “Notarii” erano i segretari dell’Imperatore e dei Governatori delle varie Province. Sempre nel tardo impero, più vicino alla figura del Notaio odierno era il “Tabellio”, il quale effettivamente aveva le funzioni di redigere scritture private, pur senza essere investito di alcuna funzione pubblica. Si deve infine citare anche il “Libripens”, che, invece, era a tutti gli effetti un funzionario pubblico il cui compito era assistere alle compravendite. Dotato di bilancia e pesi (che servivano per quantificare il prezzo in denaro di un determinato prodotto) e di una verga (festuca), egli batteva quest’ultima sull’oggetto in questione per formalizzare il passaggio di proprietà, una volta avvenuta la compravendita.
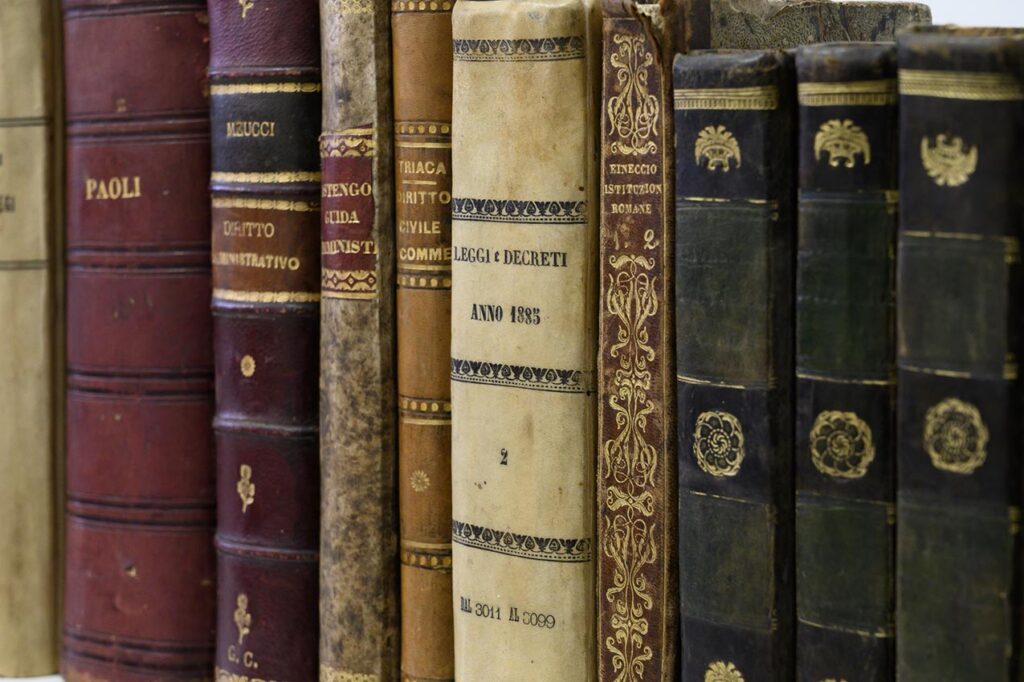
Dopo l’VIII secolo e con Carlo Magno, gli strumenti dei Notai acquistano la stessa forza ed i medesimi effetti di una sentenza passata in giudicato. .Anche durante il Medioevo, il notariato ha avuto il suo sviluppo incentrato a dare certezza nei rapporti giuridici. I Notai, come i Giudici, facevano parte delle Arti Maggiori nel Comune medievale. Fino al XVIII secolo, tuttavia, la parola “Notaio” continuò a designare figure diverse in un ambito sociale in cui a saper leggere e scrivere era comunque una minoranza della popolazione.
L’organizzazione del notariato moderno, nei paesi dove vige il cosiddetto notariato latino, risale sostanzialmente alla Rivoluzione francese (decreto del 29 settembre 1791). L’ordinamento francese fu ricalcato, nel Regno d’Italia, dalla legge del 25 ventoso anno XI (16 marzo 1803), che improntò a sé anche le successive leggi emanate nei vari Stati italiani dopo la Restaurazione. Avvenuta l’unificazione, il notariato fu regolato in Italia dal R.D. 25 maggio 1879, n. 4900, poi sostituito dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, tuttora in vigore.
Compravendite, donazioni, permute, divisioni, datio in solutum, rent to buy, etc.
Mutui e finanziamenti ipotecari e chirografari, surroghe, accolli, rinegoziazioni, frazionamenti in quote e riduzioni, etc.
Costituzione e modifiche di società, consorzi, cooperative, cessione di quote ed azioni, cessioni ed affitti di aziende, verbali assembleari, fusioni, scissioni e trasformazioni, vidimazione ed estratti libri sociali, etc.
Costituzione e disciplina degli enti no-profit. Le Onlus. L’Impresa Sociale.
Modifiche del regime patrimoniale, trasferimenti in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, fondi patrimoniali, accordi di convivenza, etc.
Dichiarazioni di successione, testamenti, accettazioni o rinunce ad eredità, atti notori o dichiarazioni sostitutive, etc.
Il Notaio o, come veniva definito nell’antica dizione tuttora talvolta usata, “Notaro” (dal latino notare ossia “annotare”, “prender nota”), è un pubblico ufficiale la cui funzione principale è quella di attribuire, in virtù del potere riconosciutogli direttamente dallo Stato e mediante l’apposizione della propria firma e dell’impronta del proprio sigillo, pubblica fede agli atti redatti, con le richieste formalità, da esso Notaio (Art. 2699 Cod. Civ.). Attribuire pubblica fede ad un atto significa, in buona sostanza, attribuirgli valore di prova legale, così che tutti, compreso il Giudice, debbano presumere come vero ciò che è dal Notaio attestato, salvo che sia accertato giudizialmente il reato di falso.

Diversamente avviene per la scrittura privata predisposta direttamente dalle parti interessate e dalle stesse sottoscritta, mediante apposizione della propria firma autografa. La funzione del Notaio, in tale caso, è quella di autenticare dette sottoscrizioni, attestando che le stesse sono state apposte dalle parti in sua presenza, senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese. La scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio ricevente diviene, così, un documento che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta (art. 2702 – 2703 Cod. Civ.).
Da quanto sopra esposto si evince che è proprio nell’atto pubblico che si estrinseca la importante e insostituibile funzione dell’attività del Notaio, il quale, nella sua qualità di tecnico del diritto, deve indagare circa la volontà delle parti quale sia il fine economico-giuridico che le stesse intendono perseguire, e tradurla in termini giuridici nel negozio più idoneo, adeguandola alle norme imperative di Legge, al buon costume e all’ordine pubblico. In questo modo il Notaio, svolgendo una funzione di controllo preventivo di legalità, si pone come un filtro tra i cittadini e le regole poste dallo Stato. Tanto maggiore è la presenza del Notaio nei traffici giuridici, tanto minore è il rischio di una lite tra le parti: ciò a sua volta si traduce nella deflazione del carico dell’attività dei magistrati. A tale riguardo è opportuno ricordare la nota affermazione del Giurista F. Carnelutti che recitava: “Tanto più Notaio, tanto meno Giudice”.